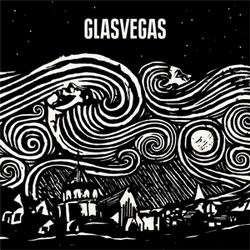Le Sorelle Marinetti – Non ce ne importa niente
11 giugno 2009 Lascia un commento
Le Sorelle Marinetti: Non ce ne importa niente (P-Nuts, 2008)
 Non ero certo privo di scetticismo quando per la prima volta mi è capitato tra le mani il cd de Le Sorelle Marinetti (peraltro uscita non recente; ma il relativo, lungo tour non è ancora terminato). Il trio, già noto agli spettatori di Gennaro Cosmo Parlato, propone infatti nel suo esordio un repertorio di brani swing portati al successo a cavallo degli anni 30 e 40 del secolo scorso da gruppi vocali come il Trio Lescano o cantanti come Silvana Fioresi e Wanda Osiris. Insomma, sentivo puzza di Puppini Sisters (il cui primo disco è uno di quelli che più mi ha irritato negli ultimi anni, le poche volte in cui sono riuscito a terminarne l’ascolto sveglio). Niente di più sbagliato. Non ce ne importa niente è un’operazione radicalmente diversa (quasi tutti brani d’epoca, rivisitati con rigore filologico) e si è rivelato ascolto stimolante e gradevole. Merito della validissima big band che accompagna Mercuria, Turbina e Scintilla rievocando i fasti musicali dell’epoca EIAR; della genialità (da riscoprire) dei parolieri dell’epoca, che infilavano allusioni-tabù (Ma le gambe) e proclami anticonformisti (La gelosia non è più di moda) in brani all’apparenza borghesi e innocenti (sì, quella bella canzone di una volta che “dopo un po’ la sa tutto il quartiere”); e ancora delle piacevoli armonizzazioni vocali delle Sorelle Marinetti e della loro interpretazione, insieme rispettosa e giocosa come si suppone essere su di un palco. In questo senso probabilmente aiuta il dettaglio fin qui non esplicitato: le signorine sono tre simpatiche drag queen. Valeva la pena di ricordarlo solo alla fine, perché il disco non punta affatto tutte le sue carte sull’elemento “teatrale”: il che giova senz’altro anche alla sua longevità.
Non ero certo privo di scetticismo quando per la prima volta mi è capitato tra le mani il cd de Le Sorelle Marinetti (peraltro uscita non recente; ma il relativo, lungo tour non è ancora terminato). Il trio, già noto agli spettatori di Gennaro Cosmo Parlato, propone infatti nel suo esordio un repertorio di brani swing portati al successo a cavallo degli anni 30 e 40 del secolo scorso da gruppi vocali come il Trio Lescano o cantanti come Silvana Fioresi e Wanda Osiris. Insomma, sentivo puzza di Puppini Sisters (il cui primo disco è uno di quelli che più mi ha irritato negli ultimi anni, le poche volte in cui sono riuscito a terminarne l’ascolto sveglio). Niente di più sbagliato. Non ce ne importa niente è un’operazione radicalmente diversa (quasi tutti brani d’epoca, rivisitati con rigore filologico) e si è rivelato ascolto stimolante e gradevole. Merito della validissima big band che accompagna Mercuria, Turbina e Scintilla rievocando i fasti musicali dell’epoca EIAR; della genialità (da riscoprire) dei parolieri dell’epoca, che infilavano allusioni-tabù (Ma le gambe) e proclami anticonformisti (La gelosia non è più di moda) in brani all’apparenza borghesi e innocenti (sì, quella bella canzone di una volta che “dopo un po’ la sa tutto il quartiere”); e ancora delle piacevoli armonizzazioni vocali delle Sorelle Marinetti e della loro interpretazione, insieme rispettosa e giocosa come si suppone essere su di un palco. In questo senso probabilmente aiuta il dettaglio fin qui non esplicitato: le signorine sono tre simpatiche drag queen. Valeva la pena di ricordarlo solo alla fine, perché il disco non punta affatto tutte le sue carte sull’elemento “teatrale”: il che giova senz’altro anche alla sua longevità.
myspace
le “prove” di Camminando sotto la pioggia
Tulipan ripresa in una loro esibizione teatrale
[ già su http://www.vitaminic.it ]